Costruzioni in zona sismica: quando la prescrizione salva dai reati edilizi

La Cassazione chiarisce i termini di prescrizione e l’applicabilità delle norme antisismiche alle strutture metalliche: principi fondamentali per proprietari e costruttori La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20124/2025 della Terza Sezione Penale, pubblicata il 9 ottobre 2025, ha affrontato questioni di grande rilevanza pratica in materia di reati edilizi commessi in zone sismiche. La decisione offre importanti chiarimenti su quando scattano e quando si prescrivono i reati legati alla costruzione abusiva di edifici, con particolare riferimento alle opere realizzate con strutture metalliche anziché in cemento armato. Il caso riguardava due persone che erano state condannate per aver realizzato opere edilizie in zona sismica in violazione della normativa antisismica prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. In particolare, erano stati contestati i reati previsti dagli articoli 44, lettera b, 64, 65, 71, 72, 93 e 94 del citato decreto. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la condanna di primo grado, rideterminando la pena in tre mesi di arresto e ottomilatrecento euro di ammenda per ciascun imputato. La questione dei termini di prescrizione Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda il calcolo dei termini di prescrizione per i reati edilizi di natura permanente. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte di Appello non aveva correttamente considerato quando i termini prescrizionali erano maturati. La vicenda presenta una complessità particolare legata alla sospensione dei termini di prescrizione prevista dall’articolo 159, comma 2, del codice penale. Questa norma ha subito nel tempo diverse modifiche legislative che hanno inciso significativamente sul calcolo della prescrizione. In origine, l’articolo era stato riformulato dall’articolo 1, comma 1, lettera e, numero 1, della legge numero 3 del 2019, nota come “legge Bonafede”. Tale legge aveva introdotto, con decorrenza dal primo gennaio 2020, la previsione secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla irrevocabilità del decreto di condanna. Tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con la legge numero 134 del 2021, che ha definitivamente abrogato l’articolo 2, comma 1, lettera a, introducendo l’articolo 161-bis del codice penale. In base a questa nuova normativa, il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha inoltre introdotto, per i reati commessi dal primo gennaio 2020, l’articolo 344-bis del codice di procedura penale, che prevede l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro determinati termini. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la recentissima sentenza numero 20989 del 12 dicembre 2024, hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’articolo 159 del codice penale, nel testo introdotto dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2017 numero 103, si applica ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019 numero 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021 numero 134. Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020, invece, si applica la disciplina posta a sistema dalla legge numero 134 del 2021. Nel caso specifico, essendo stati i reati commessi il 7 luglio 2018, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2017 numero 103. Di conseguenza, la prescrizione maturerebbe in data 5 giugno 2026 senza considerare i periodi di sospensione del procedimento previsti dalla legge. Considerando anche le diverse sospensioni legate all’emergenza COVID-19 e ai rinvii per legittimo impedimento delle parti, il termine di prescrizione risultava comunque già decorso al momento della pronuncia della sentenza di primo grado avvenuta il 19 giugno 2023. La Corte ha inoltre ricordato che per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge numero 103 del 2017 aveva modificato il previgente articolo 159, comma 2, del codice penale, introducendo la sospensione del corso della prescrizione sia dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sia dalla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Le costruzioni con struttura metallica e la normativa antisismica Il secondo motivo di ricorso, anch’esso accolto dalla Cassazione, riguarda una questione tecnica di grande importanza pratica: quando si applicano gli articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 che disciplinano le opere in cemento armato nelle zone sismiche? La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile la disciplina penale prevista per le opere in cemento armato anche alle strutture realizzate con travi in ferro, basandosi esclusivamente sul fatto che l’opera presentava comunque una struttura metallica potenzialmente pericolosa in zona sismica. La Suprema Corte ha invece affermato un principio di diritto consolidato: la sfera di applicabilità degli articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, essendo evidente che il legislatore intende regolare anche, singolarmente, le opere che non sono composte di cemento armato ma possiedono una struttura metallica. La ratio della disposizione si spiega infatti in ragione della potenziale pericolosità della struttura metallica derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che vengano adottate le particolari precauzioni previste per la costruzione in zona sismica. Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione ha anche precisato che la disciplina penale in materia di opere a struttura metallica si applica soltanto quando la statica delle opere eseguite è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante. Nel caso di specie, come emergeva chiaramente dalle dichiarazioni del tecnico del Comune che aveva effettuato il sopralluogo, le opere contestate non erano realizzate in cemento armato ma utilizzavano blocchi di poroton e travi in ferro. Pur non essendo l’opera realizzata in cemento armato, presentava quindi
Come si valuta la lievità di un reato: i criteri della particolare tenuità secondo la Cassazione

La Sesta Sezione Penale fissa i paletti per distinguere i reati bagatellari da quelli meritevoli di sanzione: valore del bene, modalità della condotta ed esiguità del danno sotto la lente dei giudici Quando un fatto costituisce reato ma l’offesa è così ridotta da non giustificare una condanna? Questa domanda attraversa quotidianamente le aule di giustizia e tocca da vicino chiunque si trovi coinvolto in un procedimento penale per condotte di modesta gravità. La risposta non è semplice né automatica, perché richiede una valutazione articolata che deve considerare molteplici elementi concreti della fattispecie. Un caso recente deciso dalla Cassazione nella sentenza R.G.N. 21343/2025 del 22 ottobre 2025 offre l’occasione per approfondire proprio questi criteri di valutazione. Un imputato era stato condannato per sottrazione di beni sottoposti a sequestro, reato previsto dall’art. 334 del codice penale, dopo aver rimosso un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo da un garage dove avrebbe dovuto rimanere custodita. La vicenda si è conclusa con l’annullamento della sentenza da parte della Suprema Corte, che ha ritenuto insufficiente la valutazione operata dai giudici di merito sulla particolare tenuità del fatto. Il cuore della questione riguarda l’art. 131-bis del codice penale, una norma fondamentale che consente di escludere la punibilità nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando ricorrono congiuntamente tre condizioni essenziali. La prima condizione attiene alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, valutate nella loro dimensione complessiva. La seconda richiede che l’offesa risulti di particolare tenuità, un concetto giuridico che necessita di essere riempito di contenuto attraverso un’analisi concreta del caso. La terza condizione impone che il comportamento non sia abituale, escludendo quindi dal beneficio chi ha già commesso in passato condotte analoghe. Il primo elemento che il giudice deve valutare riguarda il valore economico del bene oggetto del reato. Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’imputato aveva rimosso un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di copertura assicurativa. La difesa aveva insistito sul fatto che il veicolo possedesse un valore economico infimo, un dato fattuale che assume rilevanza decisiva nella valutazione della particolare tenuità. Quando parliamo di valore economico nel contesto dell’art. 131-bis del codice penale, non ci riferiamo a una soglia fissa stabilita dalla legge, ma a un criterio elastico che deve essere apprezzato in concreto dal giudice tenendo conto del tipo di reato, delle circostanze specifiche e del contesto complessivo della vicenda. Pensare al valore del bene significa chiedersi quale sia l’entità patrimoniale dell’interesse leso dalla condotta. Un’autovettura di scarsissimo valore commerciale, magari vecchia, malandata o prossima alla rottamazione, incide in modo molto diverso rispetto a un veicolo di recente immatricolazione o comunque dotato di un valore di mercato apprezzabile. Questa valutazione non è mai astratta o basata su categorie generali, ma richiede una verifica puntuale delle condizioni concrete del bene al momento della commissione del fatto. Il secondo criterio fondamentale attiene alle modalità della condotta. L’art. 131-bis del codice penale richiede che le modalità con cui il reato è stato commesso siano tali da rendere l’offesa particolarmente tenue. In altri termini, non basta che il danno sia piccolo, ma occorre che anche il modo in cui l’azione criminosa si è realizzata presenti caratteristiche di scarsa gravità. Nel caso deciso dalla Suprema Corte, l’imputato aveva rimosso il veicolo dal garage dove era custodito e aveva fornito informazioni generiche agli agenti di pubblica sicurezza sul nuovo luogo in cui si trovava. Questa modalità della condotta va scrutinata per comprendere se denoti una particolare aggressività, spregiudicatezza o capacità di offendere il bene giuridico protetto, oppure se si sia trattata di una condotta caratterizzata da minore disvalore. Valutare le modalità della condotta significa analizzare elementi come la clandestinità dell’azione, l’eventuale uso di violenza o minaccia, il grado di pianificazione, la durata nel tempo della condotta illecita, la presenza di comportamenti volti a occultare il fatto o a impedirne la scoperta. Una sottrazione di beni sotto sequestro realizzata con modalità particolarmente subdole, oppure accompagnata da false dichiarazioni agli organi di controllo, presenta un disvalore ben diverso rispetto a una condotta ingenua, immediata, priva di artifizi o raggiri. Il giudice deve quindi entrare nel merito delle concrete circostanze del fatto, senza fermarsi alla mera constatazione che gli elementi oggettivi del reato sono integrati. Il terzo elemento essenziale è l’esiguità del danno o del pericolo. Questo criterio opera su un piano diverso rispetto al valore del bene, perché considera l’effetto complessivo della condotta sull’interesse protetto dalla norma penale. Nel reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, l’interesse tutelato non è soltanto il valore economico del bene, ma anche e soprattutto l’efficacia dei provvedimenti giudiziari e il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia. Quando un bene viene sottratto al vincolo del sequestro, si crea un pregiudizio sia sul piano patrimoniale sia sul piano della funzionalità del sistema processuale. Valutare l’esiguità del danno significa quindi considerare entrambe queste dimensioni. Da un lato, il danno patrimoniale vero e proprio, che nel caso di un veicolo di scarsissimo valore risulta molto contenuto. Dall’altro lato, il danno all’amministrazione della giustizia, che può variare sensibilmente a seconda delle circostanze concrete. Se l’imputato ha semplicemente spostato il veicolo fornendo comunque indicazioni sulla sua ubicazione, il danno al funzionamento della giustizia risulta assai meno grave rispetto al caso in cui il bene sia stato fatto sparire, distrutto o reso irreperibile. La particolare tenuità dell’offesa rappresenta poi una valutazione di sintesi che il giudice deve operare considerando congiuntamente tutti gli elementi analizzati. Non è sufficiente che uno solo dei criteri sia soddisfatto, ma occorre che dall’esame complessivo delle modalità della condotta, del valore del bene, dell’entità del danno e del pericolo emerga un quadro caratterizzato da offensività minima. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di particolare tenuità richiede una valutazione che non si limiti agli aspetti quantitativi, ma consideri anche la dimensione qualitativa dell’offesa. Questo significa che anche un danno economicamente contenuto può non integrare i presupposti della particolare tenuità se le modalità della condotta denotano un elevato disvalore o se la lesione dell’interesse protetto assume
Satira politica o diffamazione? La Cassazione traccia i confini della critica durante l’emergenza COVID-19

La Suprema Corte annulla la condanna per diffamazione di un cittadino che aveva criticato l’operato del sindaco evocando il personaggio di “Cetto La Qualunque”: quando la satira rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica politica Il confine tra critica politica legittima e diffamazione punibile rappresenta da sempre uno dei temi più delicati nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione. La questione diventa ancora più complessa quando la critica assume forme satiriche o caricaturali, evocando personaggi cinematografici notoriamente associati a comportamenti grotteschi e paradossali della classe politica. Con la sentenza n. 1127 del 17 ottobre 2025, depositata dalla Quinta Sezione Penale (R.G. 23999/2025), la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su quando l’utilizzo della satira politica rientri nell’esercizio del diritto di critica, anche nei confronti di amministratori locali durante l’emergenza pandemica da COVID-19. Il caso concreto: una mail durante la pandemia La vicenda trae origine da un episodio verificatosi durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un cittadino aveva inviato al primo cittadino del proprio Comune una comunicazione elettronica nella quale, contestando le modalità di gestione delle misure anti-contagio sul territorio comunale, faceva riferimento al “Signor Cetto La Qualunque”, personaggio satirico creato dall’attore Antonio Albanese, noto per incarnare in forma caricaturale i vizi e le degenerazioni della politica italiana. Il sindaco aveva ritenuto che tale appellativo integrasse un’offesa alla propria reputazione personale e professionale, tale da giustificare l’avvio di un’azione penale per il reato di diffamazione aggravata. Il Tribunale in primo grado e successivamente la Corte d’appello avevano accolto questa prospettazione, condannando il cittadino ai sensi degli artt. 336, 341-bis e 595 c.p. (norme che puniscono rispettivamente l’oltraggio, la diffamazione nei confronti di un pubblico ufficiale e la diffamazione aggravata), oltre a disporre la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita. La questione giuridica: satira come forma di critica o gratuita offesa? Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello davanti alla Cassazione, contestando che i giudici di merito avessero qualificato come diffamatoria una critica che, pur utilizzando il riferimento a un noto personaggio satirico, rientrava nel legittimo esercizio del diritto di critica politica garantito dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La questione centrale posta all’attenzione della Suprema Corte può essere così sintetizzata: è lecito criticare l’operato di un amministratore pubblico evocando un personaggio satirico che, nell’immaginario collettivo, rappresenta in forma grottesca le disfunzioni della classe politica italiana? Oppure tale richiamo integra necessariamente un’offesa alla reputazione personale del destinatario, configurando il reato di diffamazione? Il quadro normativo: reputazione, critica politica e satira Per comprendere la portata della decisione, occorre richiamare i principi normativi di riferimento. L’art. 595 c.p. punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione. La reputazione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, si identifica con la considerazione sociale di cui una persona gode presso la comunità di riferimento, secondo il particolare contesto storico e culturale. La tutela penale della reputazione rappresenta, tuttavia, uno dei limiti alla libertà di espressione garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10, comma 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato che nell’ambito del discorso politico la libertà di espressione assume la massima importanza, riconoscendo margini più ampi alla critica nei confronti delle personalità politiche rispetto ai semplici cittadini. Le figure pubbliche, infatti, si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini. Particolarmente rilevante è il principio secondo cui non sussiste il reato di diffamazione quando le espressioni utilizzate, pur se aspre e sferzanti, rientrano nell’esercizio del diritto di critica politica sotto forma di satira. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di diritto di critica, ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione. È ammesso l’uso dell’argumentum ad hominem, inteso a screditare il destinatario pubblico mediante l’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, purché a criticarne i programmi e le azioni, mentre è vietato l’uso gratuito di tale argomento per un’aggressione alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. La soluzione della Cassazione: il personaggio satirico come legittima critica La Quinta Sezione Penale ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di condanna. Il Collegio ha ritenuto fondate le censure proposte dal ricorrente, sottolineando innanzitutto che nel caso concreto l’ipotesi accusatoria si fondava sull’accostamento, di evidente contenuto critico, del destinatario della comunicazione a un personaggio cinematografico satirico, frutto dell’invenzione artistica, che si connota in senso dispregiativo. La Corte ha precisato che occorreva stabilire se nell’appellativo rivolto al sindaco, con il riferimento al “famoso personaggio caricaturale, interprete del malaffare politico-mafioso, avido e corrotto, interpretato dall’attore Antonio Albanese”, potesse configurarsi un’offesa alla reputazione del primo cittadino, oppure se la condotta dell’autore della comunicazione potesse ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto), in quanto riconducibile all’esercizio del diritto di critica sotto forma di satira politica. Nel rispondere a tale quesito, la Suprema Corte ha richiamato i principi consolidati secondo cui la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale di riferimento, secondo il particolare contesto storico. La protezione della reputazione rappresenta uno dei limiti all’esercizio della libertà di espressione e delle altre libertà ad essa correlate, espressamente ammessi dall’art. 10, comma 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte di Strasburgo, proprio in relazione a tale disposizione normativa, si era tradizionalmente soffermata sulla tutela della reputazione in tema di libertà di stampa, per poi ricondurre l’ambito della protezione entro la previsione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, disciplinante il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la giurisprudenza europea, perché sia applicabile tale ultima disposizione, l’offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità ed essere stata
Pene sostitutive e riforma Cartabia: quando il carcere non è l’unica risposta
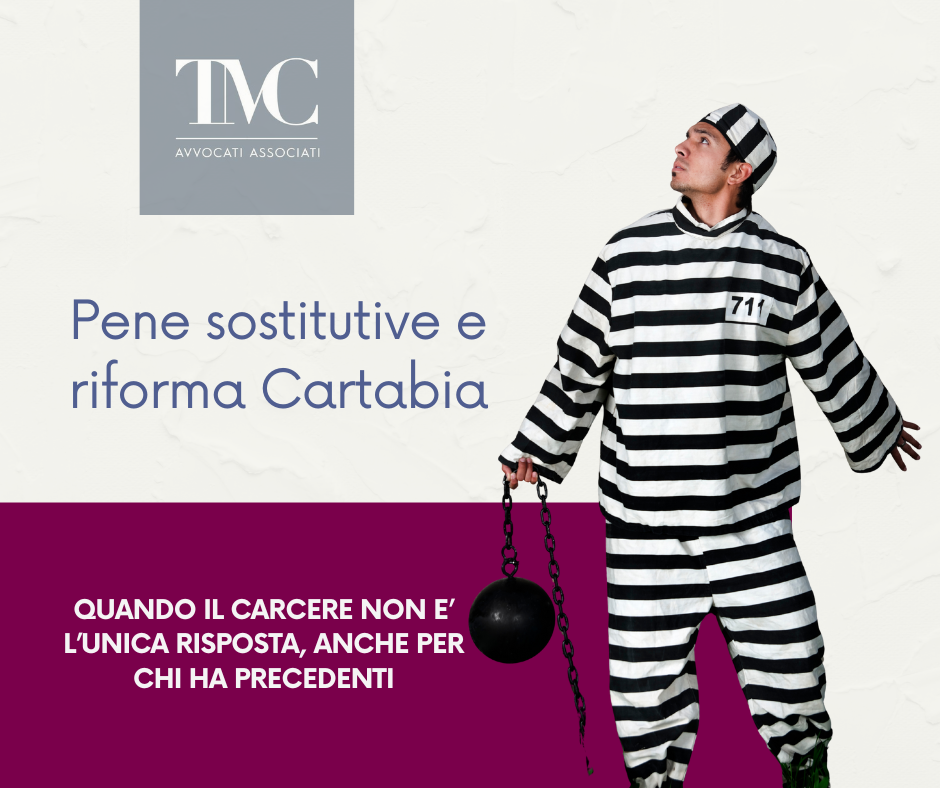
La Cassazione richiama i giudici a valutare concretamente le potenzialità rieducative delle pene alternative, soprattutto quando la condanna è minima Con sentenza n. 34243 depositata il 20 ottobre 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione interviene su una questione di fondamentale importanza per l’attuazione della riforma Cartabia: l’applicazione delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis del codice penale. La pronuncia segna un punto di svolta nell’interpretazione del nuovo assetto normativo introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022, affermando che il giudice non può limitarsi a considerare i precedenti penali per negare una pena alternativa al carcere, ma deve compiere una valutazione prognostica complessa e motivata che tenga conto delle specifiche potenzialità rieducative della sanzione richiesta. La vicenda trae origine da un episodio di cronaca giudiziaria apparentemente minore: il tentativo di sottrarre generi alimentari del valore di 62 euro da un supermercato. La donna protagonista della vicenda veniva condannata dal Tribunale di Vercelli a due mesi di reclusione per tentato furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Torino. La difesa impugnava in cassazione su tre profili: la configurabilità dell’aggravante, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, soprattutto, il diniego della pena sostitutiva richiesta. La videosorveglianza non esclude l’aggravante del furto Sul primo profilo la Cassazione ha confermato l’orientamento consolidato in materia di furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede. La difesa aveva sostenuto che la presenza di controllo da parte del direttore del supermercato – controllo che aveva portato all’interruzione del reato e quindi alla sua qualificazione come tentato anziché consumato – avrebbe dovuto escludere l’aggravante prevista dall’art. 625, primo comma, n. 7 del codice penale. La Suprema Corte ha respinto questa censura richiamando un principio ormai consolidato: sussiste l’aggravante qualora il furto della cosa esposta alla pubblica fede sia commesso in un luogo dotato di sistema di videosorveglianza che, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate, non costituisce di per sé una difesa idonea a impedire la consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo, né garantisce in maniera continuativa la custodia del bene da parte del proprietario o di altra persona addetta alla sorveglianza. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva escluso del tutto la sussistenza di un sistema di sorveglianza con operatore addetto e pronto a impedire la commissione del furto, rilevando come l’azione criminosa fosse stata arrestata in modo accidentale. La ricorrente non aveva dedotto alcun travisamento della prova su questo punto, limitandosi a proporre una alternativa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata. Il motivo di ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per genericità. L’abitualità del reato esclude la non punibilità per tenuità del fatto Il secondo motivo di ricorso lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non si fosse confrontata né con il tempo trascorso tra i reati precedenti e quello oggetto di giudizio, né con le circostanze della pregressa esecuzione di alcune pene, né con il comportamento susseguente al reato. Anche questo motivo è stato respinto come aspecifico. La sentenza impugnata aveva richiamato i precedenti penali dell’imputata, non solo risalenti ma anche relativi a tempi recenti, ai fini della prova dell’abitualità del reato. In particolare, tra le condanne subite emergeva anche una sentenza del 5 gennaio 2023 della Corte d’Appello di Torino che confermava la condanna per un furto commesso il 14 gennaio 2021, quindi successivo a quello per cui si procedeva. La Cassazione ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis, il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. Nel caso concreto l’abitualità era attestata dai reati precedenti come anche da quello successivo, rendendo ogni ulteriore doglianza assorbita dalla preliminare valutazione di sussistenza dell’abitualità, che costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’esimente anche in presenza di un fatto di lieve entità. Le pene sostitutive come autentiche pene: la svolta della riforma Cartabia Il terzo motivo di ricorso – l’unico accolto dalla Suprema Corte – attiene al diniego della pena sostitutiva prevista dall’art. 20-bis del codice penale. La difesa aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, lamentando che la motivazione della Corte d’Appello si fosse limitata alla valutazione dei precedenti penali senza tenere in conto la misura della pena detentiva applicata, pari a soli due mesi di reclusione, e lo spirito della riforma Cartabia. La Corte territoriale aveva rilevato che le pene sostitutive non sarebbero state idonee alla rieducazione e, soprattutto, non avrebbero assicurato la prevenzione del pericolo di commissione di reati, tenuti in conto i numerosi e specifici precedenti che non risultavano aver costituito una remora per l’imputata. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione contraddittoria e insufficiente, accogliendo il ricorso e annullando la sentenza con rinvio limitatamente al profilo delle pene sostitutive. La pronuncia si fonda su una ricostruzione sistematica della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, che ha profondamente modificato la natura e la funzione delle pene sostitutive nel sistema sanzionatorio italiano. Come evidenziato dalla Suprema Corte, la riforma ha inteso configurare le pene sostitutive come autentiche pene, destinate ad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione penale. Ciò si desume dall’introduzione nel Libro I del codice penale del nuovo art. 20-bis, che espressamente le elenca, completando il novero delle pene principali e accessorie. La Cassazione richiama espressamente la relazione illustrativa del D.Lgs. n. 150/2022, che chiarisce come le pene sostitutive debbano intendersi come vere e proprie pene diverse da quelle edittali, irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato nonché a obiettivi di prevenzione generale e speciale. Questo nuovo assetto normativo si pone in coerenza con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione, che ragiona di “pene” al plurale, stimolando
Bancarotta fraudolenta: quando i prelievi dell’amministratore diventano distrazione

La Cassazione chiarisce i limiti dei compensi degli amministratori nelle società in crisi e stabilisce importanti principi sulla prova della distrazione La Corte di Cassazione, con sentenza della Quinta Sezione Penale n. 30526 del 10 settembre 2025, ha affrontato una questione di fondamentale importanza per amministratori e società: quando i prelievi di denaro dalle casse sociali da parte dell’amministratore configurano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione piuttosto che bancarotta preferenziale. Il caso concreto: piccoli prelievi, grandi conseguenze La vicenda oggetto della pronuncia riguardava un’amministratrice e socia di una società in nome collettivo dichiarata fallita nel novembre 2016. L’imputata aveva effettuato nel corso di quattro anni molteplici piccoli prelievi dalle casse sociali per un importo complessivo di 342.269 euro, sostenendo che tali somme le spettassero come compenso per l’attività di amministrazione svolta. La strategia difensiva si basava sull’affermazione che questi prelievi costituissero legittima retribuzione per il lavoro prestato nell’interesse della società. Inoltre, l’amministratrice aveva venduto beni e attrezzature aziendali senza rendere conto della destinazione dei proventi ricavati. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione ex art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall. e bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall. Il ricorso in Cassazione, articolato su sei motivi di impugnazione, è stato integralmente rigettato, offrendo così l’occasione alla Suprema Corte di consolidare principi fondamentali in materia. Il principio cardine: nessun automatico diritto al compenso La Cassazione ha chiarito definitivamente che il rapporto tra amministratore e società non è assimilabile a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Come spiegato nella motivazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione sono legati alla società da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso nei rapporti tutelati e non rientra nell’ambito di protezione assicurato dall’art. 36 Cost. Questo significa che non esiste un automatico diritto al compenso derivante semplicemente dallo svolgimento delle funzioni amministrative. La Corte ha precisato che tale principio vale tanto per le società di capitali quanto per le società di persone, come la società in nome collettivo oggetto del caso. Per le società di persone, la conclusione vale ancor di più, atteso che il potere di amministrare è strettamente connesso alla responsabilità illimitata del socio, che ha un preciso interesse a svolgere l’attività gestoria. L’onere della prova ricade sull’amministratore Quando un amministratore preleva somme dalle casse sociali sostenendo di averne diritto come compenso, deve dimostrare specifici elementi che giustifichino tale pretesa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre fornire dati ed elementi di confronto che consentano un’adeguata valutazione, quali gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti. Nel caso concreto, l’imputata non era riuscita a fornire elementi sufficienti a giustificare prelievi per oltre 340.000 euro in quattro anni. I suoi assunti sulla misura del compenso spettante sono stati definiti dalla Corte generici, apodittici e inidonei a superare la soglia del giudizio di legittimità. La mancanza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso ha reso ancora più stringente l’onere probatorio a carico dell’amministratrice. Distrazione, non preferenza: una distinzione cruciale Un aspetto particolarmente rilevante della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica dei prelievi. La strategia difensiva sosteneva che si trattasse di bancarotta preferenziale, reato meno grave che presuppone l’esistenza di un credito legittimo ma il cui pagamento avvantaggia indebitamente il creditore rispetto agli altri. La Cassazione ha invece confermato la qualificazione come bancarotta fraudolenta per distrazione, spiegando che commette questo più grave reato l’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione. Il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di lavoro che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato. L’elemento soggettivo: basta il dolo generico Per quanto riguarda l’aspetto psicologico del reato, la Cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico. Non è necessario dimostrare che l’amministratore fosse consapevole dello stato di insolvenza dell’impresa né che avesse l’intenzione specifica di recare pregiudizio ai creditori. È sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, come stabilito da Cass. S.U. n. 22474 del 31/03/2016. Nel caso specifico, il continuativo prelievo di somme che si sono rivelate di importo ingente ha attestato la consapevolezza dell’imputata di dare a tali somme una destinazione diversa dalle esigenze aziendali, tanto più considerando l’ingente esposizione debitoria della società, particolarmente nei confronti dell’erario. L’inversione dell’onere della prova per i beni aziendali Un altro aspetto significativo riguarda la vendita di beni e attrezzature aziendali senza giustificazione della destinazione dei proventi. La Cassazione ha confermato il consolidato orientamento secondo cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti. Questo principio si basa sulla responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e sull’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 L. Fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa. Tale orientamento giustifica l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato. Le implicazioni pratiche per amministratori e società Questa sentenza ha importanti ricadute pratiche che meritano attenta considerazione. Per quanto riguarda gli amministratori, diventa fondamentale formalizzare sempre ogni compenso attraverso delibere assembleari o previsioni statutarie specifiche. I prelievi informali dalle casse sociali, anche se ritenuti soggettivamente legittimi, espongono a gravissimi rischi penali che possono configurare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Per le società che attraversano fasi di difficoltà, diventa cruciale mantenere una rigorosa tracciabilità
Revenge Porn: Tutela Legale e Strategie di Difesa nel Diritto Italiano
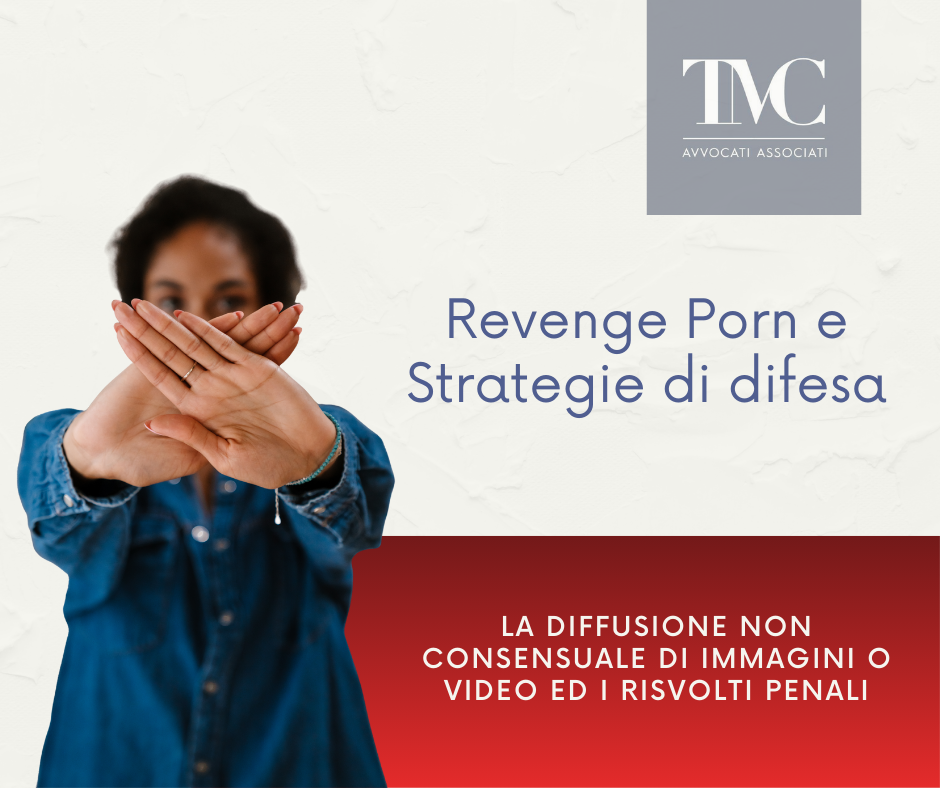
La diffusione illecita di immagini private costituisce reato penale: analisi normativa, conseguenze giuridiche e strumenti di protezione per le vittime La diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti, comunemente definita “revenge porn”, rappresenta una delle forme più insidiose di violenza digitale della nostra epoca. Questo fenomeno, disciplinato dall’art. 612-ter del Codice Penale introdotto con la Legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. “Codice Rosso”), colpisce milioni di persone in Italia, causando devastanti conseguenze psicologiche e sociali. Inquadramento Giuridico del Reato L’art. 612-ter c.p. punisce chiunque “diffonde, pubblica o cede immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata”. La norma prevede una pena edittale da 1 a 6 anni di reclusione e una multa da 5.000 a 15.000 euro, configurandosi come reato a querela di parte con termine di sei mesi dalla conoscenza del fatto. Il legislatore ha previsto un sistema di circostanze aggravanti particolarmente severo. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, attraverso strumenti informatici o telematici, oppure in danno di soggetti vulnerabili come donne in stato di gravidanza o persone in condizioni di inferiorità psico-fisica. La procedibilità d’ufficio è prevista nei casi più gravi, quali vittime in condizioni di infermità fisica o psichica, donne gravide, o quando sussiste connessione con altri delitti perseguibili d’ufficio. Significativamente, la remissione della querela è ammessa esclusivamente in sede processuale, garantendo un controllo giudiziario sulla volontà della vittima. Strumenti di Tutela e Azioni Immediate Le vittime dispongono di un articolato sistema di tutele, sia penali che amministrative. L’azione primaria consiste nella presentazione tempestiva della querela, corredata da documentazione probatoria dettagliata comprensiva di screenshot, messaggi e link ai contenuti diffusi illecitamente. Parallelamente, assume rilevanza strategica la segnalazione al Garante per la Privacy ex art. 144-bis del Codice Privacy e art. 33-bis del regolamento n. 1/2019. Tale strumento, accessibile anche ai minori, consente al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, notificando alle piattaforme coinvolte per contrastare immediatamente la diffusione. Le vittime possono inoltre richiedere direttamente ai gestori delle piattaforme online la rimozione immediata dei contenuti illeciti, procedendo con ingiunzione giudiziaria in caso di mancata collaborazione. Questa strategia multilivello massimizza l’efficacia dell’intervento di tutela. Profili Risarcitori e Danno La configurazione del revenge porn come reato consente alla vittima di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno. La giurisprudenza riconosce diverse tipologie di danno risarcibile: il danno morale per la sofferenza emotiva e psicologica, il danno biologico per le conseguenze sulla salute psico-fisica, il danno esistenziale per la compromissione delle relazioni personali e della reputazione, e il danno materiale per le perdite economiche dirette. La quantificazione del danno viene personalizzata dal giudice considerando l’entità della diffusione, la durata dell’esposizione mediatica, le conseguenze sulla vita privata e professionale della vittima, nonché l’impatto psicologico documentato attraverso certificazioni medico-psicologiche. Dimensione Sociologica del Fenomeno I dati emersi dalla ricerca campionaria condotta su 2.000 utenti internet italiani evidenziano l’allarmante diffusione del fenomeno: il 4% degli italiani risulta vittima di revenge porn, con una stima di almeno 2 milioni di persone coinvolte. L’età media ponderata delle vittime si attesta sui 27 anni, con una prevalenza femminile del 70%. Preoccupante appare la scarsa consapevolezza normativa: il 17% della popolazione è erroneamente convinta che non costituisca reato in Italia, percentuale che sale al 35% tra le vittime stesse. Solo il 50% delle vittime presenta denuncia, principalmente per vergogna, tentativo di mediazione diretta con il responsabile, o timore che la vicenda diventi di dominio pubblico. Strategie di Prevenzione e Tutela Proattiva La prevenzione rappresenta la prima linea di difesa contro il revenge porn. È fondamentale sviluppare consapevolezza sui rischi della condivisione di contenuti intimi, considerando che su internet “niente viene mai completamente cancellato”. Le misure di sicurezza digitale includono l’utilizzo di password complesse, crittografia, antivirus aggiornati, mantenimento della privacy degli account social e prudenza nell’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche. L’educazione digitale assume particolare rilevanza per i minori, attraverso il monitoraggio del comportamento online e la sensibilizzazione sui rischi della diffusione di informazioni personali. Esistono inoltre strumenti preventivi innovativi che consentono di tracciare e proteggere le immagini impedendo la diffusione non consensuale. Evoluzione Tecnologica e Nuove Sfide L’avvento dell’intelligenza artificiale ha introdotto nuove forme di violenza digitale attraverso i “deepfake”, che permettono di associare volti reali a corpi nudi virtuali. Questo fenomeno amplia significativamente il perimetro del revenge porn, rendendo potenzialmente vittima chiunque abbia immagini pubbliche su internet. La risposta giuridica a queste nuove forme di violenza digitale richiede un costante adeguamento normativo e interpretativo, nonché lo sviluppo di competenze specialistiche da parte degli operatori del diritto. Conclusioni e Prospettive Il revenge porn rappresenta una forma grave di violenza digitale che richiede un approccio integrato tra tutela penale, civile e amministrativa. La legislazione italiana, pur moderna e severa, necessita di essere supportata da campagne di sensibilizzazione capillari e da un rafforzamento delle competenze specialistiche degli operatori giuridici. La cultura del rispetto digitale deve essere promossa attraverso l’educazione, la prevenzione e il supporto multidisciplinare alle vittime, che necessitano non solo di tutela legale ma anche di assistenza psicologica per superare le profonde ferite lasciate da questa forma di violenza. Se sei vittima di revenge porn o necessiti di consulenza specialistica in materia di diritto penale dell’informatica, il nostro Studio è a disposizione per fornirti assistenza legale qualificata e supportarti nel percorso di tutela dei tuoi diritti. Contattaci per una consulenza riservata.
Prelievi ematici senza consenso: quando gli esami alcolemici sono inutilizzabili

La Cassazione ribadisce l’obbligo di avviso preventivo negli accertamenti ospedalieri per guida in stato di ebbrezza Con sentenza n. 28203/2025, la Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale contro una sentenza di assoluzione per guida in stato di ebbrezza, confermando un principio fondamentale nella tutela dei diritti della persona sottoposta a indagini. La vicenda processuale Il caso traeva origine da un incidente stradale notturno che aveva coinvolto un ciclomotore. Il conducente, sbalzato dal veicolo a causa di un dosso, era stato trasportato in ospedale dove il personale sanitario aveva proceduto agli accertamenti dell’alcolemia. Tuttavia, secondo quanto accertato dal Tribunale di Gorizia nella sentenza del 6 novembre 2024, non era stata fornita la prova che il personale ospedaliero avesse effettivamente dato all’indagato gli avvisi previsti dall’art. 114 disp.att. cod.proc.pen. L’imputazione si basava sulla violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b), comma 2 bis e comma 2 sexies del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), che disciplina la guida sotto l’influenza dell’alcol. I principi giuridici consolidati La Suprema Corte ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. Questo obbligo sussiste non soltanto quando viene richiesta l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria per l’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando tale accertamento viene svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente dalla struttura sanitaria per finalità diagnostiche e di cura. La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza precedente, citando diverse decisioni che hanno consolidato questo principio: Sez. 4, n. 5891 del 25/01/2023; Sez. 4 n. 16699 del 14/04/2021; Sez. 4 n. 11458 del 12/02/2021; Sez. 4, n. 40807 del 04/07/2019; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019; Sez. 4 n. 27490 del 21/05/2019. L’aspetto procedurale: l’inammissibilità del ricorso Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile per carenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. La censura si concentrava sulla mancata prestazione del consenso da parte dell’imputato all’effettuazione del prelievo ematico, ma secondo la Cassazione non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva infatti fondato l’assoluzione sulla mancata prova relativa agli avvisi richiesti dalla legge in ordine agli accertamenti medici richiesti dalla Procura, applicando correttamente l’orientamento di legittimità prevalente. Le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti Questa decisione conferma l’importanza fondamentale del rispetto delle garanzie procedurali negli accertamenti relativi alla guida in stato di ebbrezza. Per i cittadini, significa che qualsiasi prelievo ematico effettuato senza il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore comporta l’inutilizzabilità degli esami ai fini processuali. Per gli operatori del diritto, la sentenza ribadisce che l’obbligo di avviso sussiste anche quando il prelievo ematico viene effettuato autonomamente dalla struttura sanitaria per finalità mediche e successivamente utilizzato per accertamenti giudiziari. Non è sufficiente che il prelievo sia stato effettuato per scopi di cura: quando viene utilizzato ai fini processuali, devono essere rispettate tutte le garanzie procedurali previste dalla legge. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di una corretta documentazione delle procedure seguite dal personale sanitario e dalle forze dell’ordine, poiché l’onere della prova ricade su chi vuole utilizzare i risultati dell’accertamento nel processo penale. Riflessioni conclusive La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante richiamo al rispetto dei diritti fondamentali della persona anche nelle situazioni di emergenza sanitaria. Il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza stradale e la tutela dei diritti individuali deve sempre passare attraverso il rigoroso rispetto delle procedure previste dal codice di procedura penale. Il tuo caso presenta profili simili? Il nostro studio è specializzato in diritto penale e procedura penale. Contattaci per una consulenza personalizzata e scopri come tutelare i tuoi diritti in situazioni complesse come questa.
DETENZIONE DI STUPEFACENTI: QUANDO È REATO E QUANDO È ILLECITO AMMINISTRATIVO

Il confine tra l’illecito penale e quello amministrativo in materia di stupefacenti rappresenta una questione cruciale nel diritto penale italiano, con implicazioni significative per i soggetti coinvolti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre l’occasione per analizzare questo discrimine con particolare attenzione all’onere probatorio e ai criteri normativi utilizzati dai tribunali. Il quadro normativo di riferimento Il discrimine tra il reato (art. 73 del DPR n. 309/1990) e l’illecito amministrativo (art. 75 dello stesso DPR) in presenza di condotte “neutre” – ossia non “autoevidentemente” dimostrative della destinazione “a terzi” – quale è tipicamente la mera detenzione, passa attraverso la corretta lettura dell’art. 75, comma 1 bis, lett. a), del DPR n. 309 del 1990. Questa disposizione “normativizza” i criteri da utilizzare per determinare se la detenzione di sostanze stupefacenti configuri un reato penale o un mero illecito amministrativo, introducendo parametri oggettivi per tale valutazione. La disposizione è stata introdotta dal decreto legge 20 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n. 79 e riproduce, con alcune modifiche, il contenuto dell’art. 73, comma 1 bis, lett. a), dello stesso DPR n. 309 del 1990, caducato per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale. I criteri distintivi per valutare la destinazione della sostanza Il parametro fondamentale riguarda: la “quantità” della sostanza nonché le “modalità di presentazione”, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione. 1. Il criterio quantitativo Quanto al parametro della quantità, la necessità di un apprezzamento congiunto con l’altro parametro delle modalità di presentazione delle sostanze, consente di ritenere che il mero superamento della soglia, specie se modesto, non accredita da solo, sempre e comunque, la rilevanza penale del fatto, occorrendo una disamina complessiva della vicenda. È importante sottolineare che: È evidente, peraltro, che tanto più elevato è il quantitativo della sostanza, tanto più è accreditabile la destinazione anche solo parziale al mercato. Viceversa: Un quantitativo “sotto soglia” può non escludere la rilevanza penale della condotta, alla luce delle altre circostanze della vicenda, conducenti a ritenere dimostrata la destinazione illecita (si pensi, al confezionamento frazionato in un luogo destinato allo spaccio e alla disponibilità di denaro in contanti dimostrativa di un pregresso “spaccio”). 2. Le modalità di presentazione Dalla formulazione della norma si desume che il peso lordo complessivo, il confezionamento frazionato e le altre circostanze dell’azione rilevano non come criteri autonomi, bensì come “sottocriteri” diretti a dare concretezza al parametro delle modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti. Molto utile, tra gli elementi di specificazione, è quello basato sul “confezionamento frazionato”: non ne è dubitabile la rilevanza indiziaria, giacché detto frazionamento può far fondatamente ritenere che trattasi di sostanza stupefacente destinata ad essere venduta al dettaglio sul mercato illecito. 3. Altre circostanze dell’azione Quanto poi alle “altre circostanze dell’azione”, nella relativa nozione (estremamente ampia) rientrano tutte le circostanze “oggettive” diverse dalle altre espressamente codificate (quantitativo di principio attivo, peso lordo, frazionamento della sostanza) idonee a supportare logicamente il giudizio sulla destinazione della sostanza: per esempio, vi rientrano le modalità di custodia della droga, le modalità spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro della medesima; il ritrovamento di quantitativi di sostanza da taglio, ecc. L’onere della prova: un aspetto fondamentale Un principio cardine da tenere presente è che: Per cogliere la portata e l’importanza della disposizione contenuta nell’articolo 75, comma 1 bis, lettera a), bisogna partire dal rilievo indubitabile che, nella ricostruzione del reato di cui all’articolo 73, la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è l’elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa. In altri termini: Non spetta, cioè, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso. L’onere di allegazione dell’imputato Pur non gravando sull’imputato l’onere della prova, vi è comunque un onere di allegazione: Rispetto all’onere probatorio della destinazione illecita posto a carico dell’accusa, vale piuttosto evidenziare che l’interessato ha semmai un “onere di allegazione” di segno contrario, nel senso che può controdedurre elementi probatori a proprio favore, dimostrativi della destinazione della sostanza all’uso esclusivo proprio, sì da poterne fare discendere, con l’insussistenza del fatto incriminato, solo l’applicabilità delle sanzioni amministrative. Esempi pratici dalla giurisprudenza La Cassazione ha ritenuto logicamente motivata la destinazione della sostanza allo spaccio in presenza di elementi come: Le modalità di confezionamento della sostanza stupefacente, suddivisa in bustine di cellophane, della diversa tipologia di sostanze rinvenute, del quantitativo, del denaro contante nella disponibilità dell’imputato, dell’assenza di certificazione rilasciata in suo favore come assuntore. Altrettanto significativi sono: Il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga. Il caso della tossicodipendenza certificata In questa prospettiva, essendo “interesse” dell’imputato “allegare” elementi che possano utilmente contrastare l’ipotesi accusatoria, accreditando in particolare la destinazione all’uso personale, pur essendo possibile e conosciuta la figura del consumatore che sia anche spacciatore, è fin troppo evidente che, in assenza di elementi conducenti per un’attività anche di spaccio, la certificazione dello stato di tossicodipendente, specie in presenza di quantitativi non esorbitanti, è elemento fattuale significativo per accreditare l’insussistenza dell’illecito penale. Conclusioni: una valutazione complessiva del caso concreto L’elemento chiave che emerge dalla giurisprudenza più recente è che la valutazione deve essere sempre globale e contestualizzata: Il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. Per i cittadini, è fondamentale comprendere che non è il solo quantitativo a determinare l’applicazione della sanzione penale, ma un complesso di elementi che
