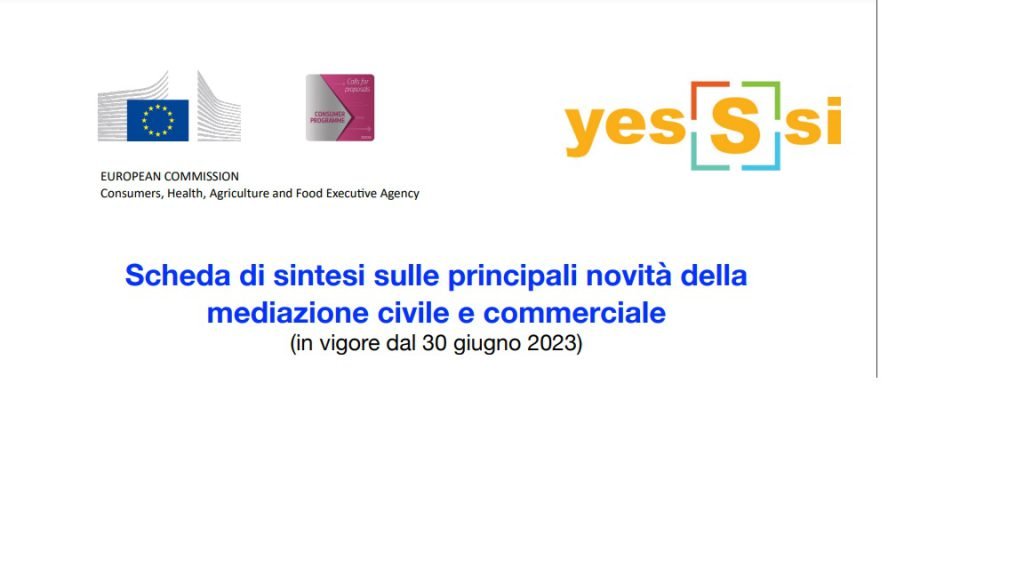PENSIONE DI SUPERSTITE ANCHE AL FIGLIO DA PROCREAZIONE ASSISTITA?

Tempo di lettura: 2 minuti La piccola “Caia” era nata molto tempo dopo la morte del padre, quando la madre aveva fatto ricorso alle tecniche di procreazione assistita, grazie alla conservazione del seme del marito. La mamma aveva poi ottenuto dalla Corte di Appello di Ancona il decreto di riconoscimento della piccola come figlia del marito scomparso; con quel provvedimento, aveva presentato infine domanda all’INPS per l’attribuzione alla minore della pensione di superstite. Ma l’Ente previdenziale aveva rigettato la richiesta, sul presupposto che tra la morte del padre e la nascita della piccola erano decorsi più di trecento giorni. L’istituto sosteneva, in analogia con quanto disposto dall’art. 232 del codice civile, che si presume concepito durante il matrimonio solo il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dal verificarsi dell’evento infausto. Il provvedimento di rigetto dell’INPS veniva perciò impugnato dalla madre dinanzi il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, il quale accoglieva l’azione e stabiliva il carattere della non perentorietà del termine dei trecento giorni, anche perché era stato già accertato il rapporto di filiazione intercorrente tra la minore e il papà scomparso. Il tribunale condannava perciò l’INPS al pagamento della “pensione ai superstiti” a favore della minore. L’istituto impugnava la decisione, sostenendo l’erronea applicazione della legge da parte del giudice di primo grado. Secondo l’appellante, l’articolo 462 comma 2 del codice civile fa rientrare tra i capaci a succedere i nati entro il trecentesimo giorno dalla morte del “de cuius”, mentre il decreto giudiziale di accertamento della paternità non poteva avere efficacia nei confronti dell’INPS, limitandosi a produrre i suoi effetti sui registri dello stato civile del comune. La Corte di Appello di Ancona non ha condiviso, tuttavia, la tesi dell’istituto, e con la sentenza n. 237 del 2 settembre 2022, ha rigettato l’appello proposto dall’INPS, confermando integralmente la decisione emessa in primo grado emessa dal tribunale. Secondo i giudici di secondo grado, l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 prevede il generale diritto del figlio minore a godere della pensione a prescindere dal momento della sua nascita, mentre è ormai pacifico l’orientamento di legittimità secondo cui le azioni di stato hanno efficacia “erga omnes”. In conclusione, ciò che rileva, secondo la Corte marchigiana, è lo status di figlio, anche alla luce dell’art. 8 della Legge n. 40 del 2004, che riconosce tale stato ai nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
SI PUO’ LICENZIARE IL LAVORATORE CON HANDICAP PER IL SUO SCARSO RENDIMENTO?

Tempo di lettura: 2 minuti Il dipendente era affetto da una malattia che lo rallentava nello svolgimento del lavoro, e perciò l’azienda, per agevolarlo, aveva ridotto le mansioni che gli erano state affidate, alleggerendolo di alcuni compiti, assegnandogli anche un’autovettura aziendale con dispositivi speciali. Cinque anni più tardi, però, la prolungata ripercussione delle condizioni fisiche del lavoratore sull’andamento della produzione aveva indotto il presidente del consiglio di amministrazione a sollecitare il direttore generale a procedere al licenziamento del dipendente per sostituirlo con altro “più capace”. Pochi mesi dopo, il direttore aveva licenziato il lavoratore affetto da handicap, ma non aveva assunto nessun altro dipendente in sua sostituzione. Ma l’email inviata dal presidente del CDA al direttore generale, con cui si suggeriva di procedere al licenziamento, era giunta nelle mani del lavoratore, che, a questo punto, aveva impugnato il licenziamento perché discriminatorio, dato che gli era stato comminato in ragione ed in dipendenza della sua minorazione. L’azienda resisteva in giudizio contestando proprio la natura discriminatoria del licenziamento, alla luce del lungo tempo trascorso dall’insorgenza della malattia invalidante e della mancata sostituzione del dipendente espulso con altra unità che ne avesse preso il posto. Condividendo le ragioni dell’azienda, il tribunale aveva rigettato il ricorso del lavoratore, mentre la Corte di Appello di Milano aveva poi ribaltato la decisione, ritenendo che il contenuto della email inviata al direttore generale rivelasse la vera ragione del licenziamento, indipendentemente dal lungo tempo trascorso dall’insorgenza della malattia e dalla mancata sostituzione del lavoratore, come invece richiesta dai vertici aziendali. La datrice di lavoro impugnava la sentenza di appello innanzi alla Corte di Cassazione, che ha espresso infine la propria valutazione, sulla delicata questione, con l’ordinanza n. 30971 del 20.10.2022, rigettando le doglianze dell’azienda, e confermando quindi l’annullamento del licenziamento. I giudici di legittimità hanno ritenuto, infatti, che la ragione del recesso non poteva che essere collocata in stretta dipendenza con la strategia indicata dal CDA nella e-mail trasmessa al direttore generale, a nulla rilevando invece né il tempo trascorso da quando era insorta la malattia e nemmeno le diverse agevolazioni concesse al lavoratore prima del licenziamento. La Cassazione ha disatteso così la censura mossa dalla datrice di lavoro circa la prevalenza di diverse ragioni di carattere organizzativo, che avrebbero fondato la decisione presa nei confronti del lavoratore, valutate dalla corte come secondarie rispetto alla ragione discriminatoria. In definitiva, per i giudici di legittimità, la mancata sostituzione del lavoratore licenziato o il lungo tempo trascorso tra l’insorgenza della malattia, non escludono la natura discriminatoria soggettiva del licenziamento, quando esso è comunque irrogato in ragione dello status di handicap del dipendente.
IL DATORE RISPONDE PER L’INFORTUNIO DEL LAVORATORE IMPRUDENTE?

Tempo di lettura: 3 minuti Non era ancora scattato l’orario di lavoro, ed un feroce incendio si era sviluppato nell’azienda agricola: le fiamme avevano già avvolto la struttura e si stavano propagando rapidamente all’allevamento in cui erano ricoverati moltissimi pulcini di tacchino. Sul posto erano giunte le forze dell’ordine, che avevano intimato a tutti i presenti di allontanarsi immediatamente dal fabbricato, cosa che aveva prontamente fatto anche il titolare dell’azienda. Uno degli operai, invece, era salito su di un “bobcat”, deciso ad entrare nell’allevamento per provare a recuperare i pulcini, prima che venissero uccisi dalle fiamme. Incurante degli ordini dell’ordine di fermarsi, rivoltogli dal maresciallo dei carabinieri, il dipendente si era perciò lanciato, sul mezzo meccanico, all’interno dell’allevamento, ma poco dopo una violenta fiammata aveva avvolto il bobcat, ferendo a morte il suo conducente. Per l’accaduto, il titolare dell’azienda si era visto contestare la violazione di molteplici norme anticendio, tra le quali la omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione degli incendi, e la mancata formazione dei dipendenti per il caso di propagazione del fuoco sul luogo di lavoro. Inoltre, il Pubblico Ministero aveva contestato al datore di lavoro il reato di omicidio colposo, per non aver predisposto tutte le misure di prevenzione idonee a garantire che il lavoratore fosse adeguatamente informato sulle manovre da evitare e sui comportamenti da tenere in circostanze come quella che si era verificata. Il tribunale aveva poi mandato assolto l’imputato, sul presupposto che le violazioni delle norme antincendio non potevano aver causato o agevolato la morte del lavoratore; di diverso avviso invece la Corte di Appello, che aveva ribaltato la decisione, condannando il titolare dell’azienda sul presupposto che la predisposizione di misure adeguate, alle quali i dipendenti sarebbero stati tenuti ad uniformarsi, avrebbe potuto scongiurare l’evento. La vicenda è giunta così all’esame della Corte di Cassazione, alla quale è toccato il compito di chiarire se, a prescindere dalla predisposizione o meno di adeguate misure di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro risponda penalmente di tutti gli infortuni originati dal comportamento di un lavoratore, anche se impulsivo ed imprevedibile. Nel caso di specie, infatti, pur in assenza della nomina di un responsabile della prevenzione o di una adeguata formazione dei lavoratori, il dipendente aveva disatteso il preciso ordine di allontanarsi dal luogo, rivoltogli anche dal maresciallo dei carabinieri intervenuti, e si era lanciato invano nell’incendio, nel tentativo di porre in salvo i pulcini ricoverati nell’allevamento. La Corte romana, con la sentenza n. 39616 del 20 ottobre 2022, ha annullato la sentenza di condanna del datore di lavoro, rinviando il processo alla Corte di Appello, in diversa composizione, per la celebrazione di un nuovo processo di secondo grado per i fatti di causa. Per i giudici di legittimità, la responsabilità penale del datore di lavoro non sussiste quando il comportamento del dipendente, nello svolgimento delle sue mansioni, sia del tutto eccezionale ed imprevedibile, e cioè si concretizzi in una condotta abnorme e radicalmente lontano da tutte le ipotizzabili scelte possibili del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Ricordando anche altre pronunce simili, la Cassazione ha concluso che il comportamento che risulti negligente, imprudente ed imprevedibile, da parte del lavoratore, pur se posto in essere nell’ambito delle mansioni che gli sono state affidate, costituisce la concretizzazione del cosiddetto “rischio eccentrico”, che esclude la responsabilità del datore, quale garante della sicurezza dei propri sottoposti. Solo quando si verifichi questa ipotesi, infatti, è del tutto ragionevole dedurre che nemmeno la puntuale e meticolosa predisposizione di tutti i presidi preventivi, compresa la formazione del personale e la designazione del responsabile della prevenzione, potrebbero scongiurare il verificarsi dell’evento dannoso – nel caso di specie mortale – a carico del lavoratore.
OFFESE IN UN GRUPPO WHATSAPP: REATO O NO ?

Tempo di lettura: 4 minuti In un gruppo di whatsapp, le amiche discutono di quanto accaduto pochi giorni prima: una di loro, dopo aver ricevuto in regalo un cucciolo di cane da un’altra, glie lo aveva restituito perché non era più in grado di accudirlo. La cosa non andava giù all’amica che aveva fatto il regalo, tanto che aveva pesantemente apostrofato l’altra per averle restituito il cucciolo. La destinataria delle offese, dopo aver risposto per le rime, aveva poi sporto denunzia contro l’altra donna per il reato di diffamazione. La questione giudiziaria si era incentrata, sin da subito, sull’inquadramento dei fatti come un’ingiuria, reato ormai depenalizzato, o come una diffamazione, che invece resta punita dal codice penale. Secondo la tesi della difesa dell’imputata, per i fatti accaduti, avrebbe dovuto parlarsi di un’ingiuria, dal momento che la destinataria aveva replicato nella chat, e quindi era presente nel gruppo in cui erano state diffuse le offese. Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva assolto infatti l’imputata, ritenendo che avesse solo ingiuriato l’amica in chat; la Corte di appello di Ancona, invece, l’aveva riconosciuta colpevole del reato di diffamazione, negando che potesse aver valore la presenza solo “virtuale” della vittima nel gruppo di whatsapp. L’imputata aveva proposto perciò ricorso per cassazione, avverso la sentenza di secondo grado, sostenendo che, dalla lettura della chat, si poteva rilevare che la persona offesa aveva immediatamente replicato alle offese pronunziate nei suoi confronti, il che significa che ella era presente e che, quindi, non si era trattato di diffamazione, ma di ingiuria. I giudici della Cassazione hanno definito la vicenda con la sentenza n. 28675 depositata il 20 luglio 2022, traendo ispirazione da una precedente pronuncia (n. 13252 del 4 marzo 2021), che aveva preso in esame una vicenda simile, verificatasi però con l’invio di e-mail offensive a più destinatari, tra cui anche l’offeso. In quell’occasione la Corte aveva già chiarito che l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone, mentre l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario. Al contrario, quando la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione, così come l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione. Nel sistema dei nuovi mezzi di comunicazione, accanto alla classica presenza fisica, nello stesso momento e luogo, di chi viene offeso, di chi offende, e degli spettatori, si verificano occasioni sostanzialmente equiparabili, realizzate con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza), grazie ai quali si realizza una presenza virtuale del destinatario delle affermazioni offensive. Pertanto, se l’offesa viene profferita nel corso di una riunione “a distanza” (o “da remoto”), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorre l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato). Quando, invece, vengono indirizzate offese (scritte o vocali) al destinatario e ad altre persone che non risultano non contestualmente “presenti” (a distanza o da remoto) ricorrono i presupposti della diffamazione. I giudici della Cassazione hanno perciò rilevato che la chat di gruppo di whatsapp consente l’invio contestuale di messaggi a più persone, le quali possono riceverli immediatamente o in tempi differiti, a seconda dell’efficienza del collegamento ad internet e del terminale su cui l’applicazione utilizzata. Dal canto loro, i destinatari possono, poi, leggere i messaggi in tempo reale e, quindi, rispondere con immediatezza ovvero, come accade molto più spesso, possono leggerli, anche a distanza di tempo, quando non sono on line ovvero, pur essendo collegati a whatsapp, si trovino impegnati in altra conversazione virtuale e non consultino immediatamente la conversazione nell’ambito della quale il messaggio è stato inviato. Quindi la percezione dell’offesa, da parte della vittima, può essere contestuale o differita, a seconda che ella stia consultando proprio quella specifica chat di whatsapp o meno; nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone (quanti sono i membri della chat), perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente; nel secondo caso si avrà invece diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente. Nella vicenda che aveva originato il processo, l’amica che aveva restituito il cucciolo, dopo un iniziale botta e risposta con quella che l’aveva epitetata, non aveva più risposto ai messaggi offensivi, neanche quando, una prima volta, l’imputata aveva scritto “e rispondi vigliacca”, reagendo solo un’ora più tardi, dal che si poteva dedurre che, dopo l’atteggiamento partecipativo iniziale per difendersi dalle accuse, la vittima aveva rinunziato al “contraddittorio”, leggendo solo in un secondo momento i messaggi che l’imputata continuava ad inviarle. Quest’ultima, dal canto suo, aveva percepito come la vittima non fosse più presente, tanto da esortarla a rispondere. La Cassazione ha pertanto concluso che era stata corretta la configurazione di reato di diffamazione operata dalla Corte di Appello, perché l’accusa aveva provato che la vittima non era rimasta collegata alla chat in tempo reale, leggendo i messaggi successivi a distanza di tempo dal momento in cui erano stati immessi sulla chat, e che quindi non poteva più considerarsi “presente”, neanche virtualmente, quando l’imputata li aveva inviati.
MULTE TUTOR: CHI DEVE PROVARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO?

Tempo di lettura: 3 minuti Erano ben quattro i verbali di accertamento con cui la Polizia stradale aveva contestato il ripetuto superamento dei limiti di velocità, rilevato con il sistema “Tutor”, ma la società proprietaria dell’autoveicolo aveva proposto ricorso al Giudice di Pace sostenendo l’illegittimità delle contravvenzioni. I motivi di impugnazione dedotti erano stati molteplici, in linea con quanto si verifica nelle tante vertenze promosse in materia, moltiplicatesi ormai esponenzialmente negli ultimi anni in risposta al fiorire degli apparecchi di rilevazione della velocità, spesso al servizio delle casse degli enti locali Sia il Giudice di Pace, sia il tribunale adito in grado di appello, avevano però rigettato tutti i motivi addotti dalla opponente a sostegno del ricorso proposto. In particolare, il Tribunale di Roma aveva disatteso, tra le altre, le doglianze sollevate dall’opponente in ordine alla mancata prova della omologazione dell’apparecchio di rilevazione della velocità utilizzato per l’elevazione delle contravvenzioni. Il giudice del secondo grado aveva ritenuto, infatti, che la presunzione di legittimità dell’azione pubblica avrebbe imposto al destinatario delle contravvenzioni di provare l’inattendibilità dell’apparecchio per non essere stato omologato o sottoposto a taratura. Nei verbali, peraltro, erano stati indicati gli estremi del decreto di omologazione dell’apparecchio, ragion per cui la opponente avrebbe potuto – e dovuto – esercitare il proprio diritto di accesso agli atti amministrativi (ai sensi della legge n. 241 del 1990) per verificare e comprovare l’esattezza dei propri assunti. La società destinataria delle contravvenzioni aveva perciò deciso di impugnare la decisione del tribunale innanzi la Corte di Cassazione, sulla base di ben sei motivi di violazione di legge. I giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 29635 del 12 ottobre 2022, hanno ritenuto di decidere la fattispecie sul solo motivo riferito alla omologazione ed alla taratura dell’apparecchio utilizzato dagli agenti accertatori, ritenendo assorbiti tutti gli altri argomenti di impugnazione. Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, non può porsi a carico all’opponente l’onere di provare il cattivo funzionamento o la omessa manutenzione del sistema tecnico di utilizzato dagli accertatori, spettando semmai alla prefettura l’obbligo di produrre in giudizio il certificato di taratura del dispositivo. La Corte ha ricordato che, secondo un principio più volte affermato, e recentemente ribadito (Cass. n. 22015/2022), a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. Per contro è irrilevante che l’apparecchiatura operi in presenza di operatorio in automatico, senza la presenza degli operatori, ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, a fronte della necessità di dimostrare o attestare, con apposite certificazioni di omologazione e conformità, il loro corretto funzionamento (Cass. n. 24757/2019 – Cass. n. 29093/2020). Inoltre, dovendo le apparecchiature di misurazione della velocità essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta alla pubblica amministrazione di dare la prova positiva della omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento (Cass. n. 14597/2021), che può essere fornita solo con la produzione in giudizio delle certificazioni di conformità e di omologazione (Cass. n. 14597/2021 – Cass. n. 18022/2018 – Cass. n. 9645/2016). Per la Cassazione non è sufficiente, per assolvere l’onere della prova in questione, la sola menzione della avvenuta omologazione e taratura dell’apparecchio che può essere contenuta nel verbale di contestazione delle infrazioni, poiché la circostanza del corretto funzionamento della strumentazione – nel momento in cui è stata rilevata la velocità contestata – non può ritenersi coperta dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., sfuggendo alla diretta percezione del pubblico ufficiale verbalizzante.
MANTENIMENTO DEI FIGLI DI GENITORI SEPARATI: COME SI CALCOLA?

Tempo di lettura: 3 minuti I genitori che si separano sono sempre tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, ma spesso la determinazione dell’ammontare della contribuzione dovuta da ciascuno di essi è oggetto di controversia. In caso di disaccordo tra i genitori, la somma periodica da porre a carico dei genitori deve essere stabilita dal giudice, il quale, secondo quanto dispone l’art. 337-ter del codice civile, deve quantificare la somma, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio quando conviveva con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il numero dei parametri che il giudice è chiamato a considerare, e la loro non facile traducibilità in termini economici, ha indotto la dottrina e le autorità giudiziarie a fissare diverse linee di interpretazione, talvolta contrastanti, proprio sul rilievo da dare a ciascuno degli indicatori citati dall’art. 337-ter c.c. Uno dei profili che ha generato maggiori difficoltà applicative è quello della proporzionalità della contribuzione a cui è tenuto ogni genitore rispetto alle proprie entrate, nel caso in cui entrambi i genitori dispongano di una propria fonte di reddito. In tale evenienza, il criterio vale solo a stabilire quanto può dare singolarmente ogni genitore, o va operata una attenta valutazione di proporzionalità anche tra i redditi dei due genitori? La differenza tra le somme quantificate secondo i due distinti metodi di indagine talvolta può essere sensibile. Secondo il primo criterio, sostenuto dalla giurisprudenza meno recente, il giudice dovrebbe estrapolare la disponibilità concreta di ciascun genitore parametrandola al suo reddito, riconoscendo poi entrambe le disponibilità al figlio, al netto dell’onere derivante a chi lo ospita e lo assiste con prevalenza.In applicazione del secondo criterio, elaborato dalla giurisprudenza più recente, la somma complessiva da corrispondere al figlio va invece determinata secondo i primi criteri indicati dall’art. 337-ter c.c. (esigenze attuali e precedente tenore di vita familiare), e poi posta carico di ciascun genitore in proporzione al reddito di ciascuno di essi. Seguendo la seconda chiave di interpretazione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribaltare l’esito di un giudizio in cui, nei gradi precedenti, era stata data invece applicazione del primo criterio. Con l’ordinanza n. 4145 pubblicata il 10.2.2023, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un genitore che aveva impugnato la decisione con cui la Corte di Appello di Brescia – tra l’altro – aveva quantificato l’assegno periodico che aveva posto a suo carico, per il mantenimento della figlia, prendendo in esame il suo solo reddito, e non anche quello dell’altro genitore, circa il quale l’altra parte non aveva prodotto alcun documento, né i giudici di merito avevano svolto indagini. Secondo i giudici di legittimità, la Corte bresciana aveva rettamente valutato la situazione reddituale del ricorrente, tenendo conto degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, anche se pro quota in concorso con la di lui moglie, ed ha valutato la condizione della figlia, priva di autosufficienza economica edimpegnata negli studi universitari. Tuttavia i giudici del secondo grado non avevano effettuato alcuna indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali della madre, ritenendo ciò non necessario, alla luce di un superato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la determinazione del contributo che per legge grava sui genitori per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell’assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonderebbe su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge (Cass. n. 18538/2013). La Corte di Cassazione ha perciò chiarito che, dalla più recente giurisprudenza è stato, invece, affermato il condiviso principio di diritto secondo cui “nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.” (Cass. n. 4811/2018; conf. Cass. n. 19299/2020). La sentenza impugnata è stata perciò cassata, con rinvio del procedimento alla medesima Corte di merito, a cui spetterà di dare applicazione al principio affermato con una nuova valutazione comparativa e proporzionale delle rispettive disponibilità reddituali dei due genitori.
EMAIL TAROCCATA E CONTO IN BANCA SVUOTATO: CHI PAGA ?

Tempo di lettura: 2 minuti Il messaggio di posta elettronica, firmato da “Intesa Security Department” aveva un tono perentorio: il tuo account è in attesa ed hai quarantotto ore per confermare le informazioni del tuo account; clicca qui per convalidare il tuo account. Preoccupato, aveva risposto al messaggio ed avviato la procedura richiesta nella e-mail; aveva poi inserito il codice cliente e la password personale, quindi il codice del dispositivo “token”, ed infine il secondo codice ricevuto con un sms dalla banca. Dopo poco, l’amara sorpresa: dal conto erano stati eseguiti due distinti bonifici verso conti di ignoti, mandando in fumo poco meno di venticinquemila euro. Il correntista, un avvocato, era andato su tutte le furie quando gli era stato negato il riaccredito delle somme sottratte dal conto, e perciò aveva citato in giudizio la banca innanzi il Tribunale di Napoli per ottenere la restituzione del maltolto. La banca, per parte sua, si era difesa sostenendo di aver predisposto ogni possibile precauzione per evitare i fenomeni di truffa informatica (phishing), che però erano stati resi vani dalla disattenzione del correntista, il quale non si era reso conto del fatto che il messaggio e-mail era stato spedito da un indirizzo chiaramente non riferibile alla banca (test@surendonk.net). La vertenza è giunta così alla decisione sulla base della documentazione depositata dalle parti. A parere del tribunale, è principio accertato quello che pone a carico della banca l’onere di dimostrare di aver predisposto tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio di internet banking, utilizzando tutti gli strumenti tecnici adeguati ad assicurare la riconducibilità alla volontà del cliente delle operazioni bancarie eseguite telematicamente. In questa prospettiva, e nel rispetto della rigorosa normativa europea in materia di servizi di pagamento, resta a carico della banca il difficilissimo compito di provare la oggettiva invalicabilità dei sistemi di sicurezza predisposti, o comunque di dimostrare l’intento fraudolento o la colpa grave dello stesso cliente. E proprio la grave disattenzione del correntista, nel caso di specie, ha indotto il Tribunale di Napoli a rigettare la pretesa dell’attore, al quale i giudici hanno contestato, nella sentenza n. 1074 del 1 dicembre 2022, di aver prestato scarsa attenzione alla provenienza ed al contenuto della e-mail che lo aveva indotto a cedere i codici identificativi del suo conto. Era pacifico, infatti, che l’accesso al sito fasullo era avvenuto da un link inviato da un indirizzo palesemente non riconducibile alla banca, con una estensione sospetta, con un testo privo del logo o di riferimenti della banca, e per buona parte sgrammaticato. Un insieme di circostanze, questo, particolarmente rilevante per un professionista dotato, per definizione, di un livello di comprensione e di elaborazione superiore alla media, e per questo ancora più idoneo a comprovare la gravità della distrazione. I giudici partenopei hanno così deciso la vertenza sentenziando il rigetto della domanda di restituzione delle somme sottratte, e condannando il legale che aveva agito in giudizio al pagamento delle spese di causa.
NOTIFICA PRESSO IL COMUNE: QUANDO E’ NULLA ?

Tempo di lettura: 3 minuti Come è noto, per avviare un giudizio civile è necessario recapitare l’atto introduttivo alla parte convenuta, con la procedura di notifica. Il codice di procedura civile dispone che la notifica vada eseguita nelle mani del destinatario, di un suo familiare o anche del portiere dello stabile, ma può accadere che l’ufficiale giudiziario non rinvenga nessuno all’indirizzo di residenza del convenuto. In tali casi, il notificante deve eseguire le opportune ricerche sul posto ed assume informazioni, e solo se queste hanno esito infruttuoso, può depositare infine l’atto da notificare presso la casa comunale del luogo di ultima residenza nota. In una situazione identica, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1176 del 17.1.2023, ha preso in esame il caso della cliente a cui il suo ex avvocato aveva notificato un atto di citazione per ottenere la condanna al pagamento di compensi non corrisposti. L’ufficiale giudiziario, recatosi alla residenza anagrafica, non aveva rinvenuto la destinataria, ed anzi aveva appreso che era stata sgomberata da quella abitazione; per questa ragione aveva attestata la sua irreperibilità secondo le “informazioni assunte in loco”, procedendo al deposito dell’atto presso la casa comunale ai sensi dell’art. 143 c.p.c. La cliente era rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ed era stata condannata al pagamento delle somme liquidate a favore dell’avvocato, ma poi aveva impugnato la decisione sfavorevole innanzi al tribunale, che tuttavia aveva confermato la decisione di primo grado. Decideva quindi di rivolgere le sue doglianze alla Suprema Corte, protestando, tra l’altro, la nullità della notifica dell’atto introduttivo del primo grado, perché eseguita dall’ufficiale giudiziario sul presupposto della sua irreperibilità, che sarebbe stata ricavata da imprecisate informazioni assunte sul luogo ove era originariamente residente. Dalla relata non risultava alcuna ulteriore indicazione che consentisse di stabilire quali ricerche fossero state in concreto effettuate e da quali fonti informative fosse emersa l’irreperibilità assoluta della destinataria. Per la validità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. occorreva invece che la mancata conoscenza della residenza, del domicilio o della dimora del destinatario non fosse stata superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza (Cass. 40467/2021). I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso con l’ordinanza n. 1176 del 2023, accertando la nullità della notifica dell’atto con cui era iniziato il processo di primo grado. Secondo i magistrati di legittimità, è necessario che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto nella relata (Cass. 18385/2003; Cass. 24107/2016; Cass. 8638/2017; Cass. 2530/2022), senza potersi utilizzare formule generiche, quale quelle adottata nel caso in esame (Cass. 24107/2016; Cass. 8638/2017; Cass. 40467/2021). Nel caso concreto, non era possibile evincere dalla relata alcuna indicazione sulle specifiche informazioni assunte e la loro adeguatezza per risalire al nuovo indirizzo della ricorrente. Pertanto il Tribunale aveva sbagliato a ritenere non conoscibile il luogo di destinazione poiché non risultante dai registri anagrafici e a causa dell’intervenuto sgombero della convenuta dalla residenza originaria, senza valutare inoltre se l’ufficiale giudiziario avesse compiuto – con la dovuta diligenza – accertamenti ulteriori, rispetto alla semplice acquisizione della certificazione anagrafica.
IL MECCANICO SPROVVISTO DI PARTITA IVA HA DIRITTO AD ESSERE PAGATO?

Tempo di lettura: 3 minuti È raro che, prima di consegnare l’autovettura all’autoriparatore, gli si chieda se sia in possesso o meno di partita I.V.A., e quindi se potrà emettere, al termine dei lavori, la regolare fattura. Quella volta, però, il cliente, una volta scoperto che il meccanico a cui si era rivolto perché riparasse due veicoli di sua proprietà ed uno del figlio, aveva negato il pagamento della somma di € 4.772, 24, a titolo di compenso per le lavorazioni ed € 3.598,54 per quanto anticipato per il costo dei ricambi acquistati. L’autoriparatore si era rivolto perciò al Tribunale di Lecce per ottenere la condanna al pagamento del cliente, che si era difeso sostenendo che l’attività lavorativa era stata realizzata contra legem, perché svolta in dispregio, oltre che dell’art. 5 della L. 122/92, anche della normativa di settore contenuta nella norma di cui all’art. 5 della legge quadro per l’artigianato n. 443 del 08.08.1985. Con sentenza n. 3214/2018, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda del meccanico, che però proponeva impugnazione innanzi la Corte di appello, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il cliente al pagamento della somma di € 2.800,00, ritenendo che non vi fosse la prova dell’ulteriore importo richiesto. A questo punto era il cliente a proporre ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando che il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che tra le parti non si era concluso un valido contratto, poiché non sarebbe stata considerata la illiceità del contratto derivante dal fatto che il meccanico titolare era sprovvisto di qualifica professionale per lo svolgimento di quell’attività. I giudici della legittimità, nell’esaminare la questione, hanno chiarito preliminarmente che, nel caso di lavoratore autonomo, nella specie meccanico, ciò che rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato, è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche nella forma tacita. La nullità del contratto prevista dall’art. 2231 c.c. – nel caso di mancanza di iscrizione agli elenchi professionali – ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. (v. Cass., n. 13342/2018). Per chiarire la differenza normativa tra il professionista iscritto all’albo rispetto al lavoratore che presta attività manuale, la Corte ha precisato che la disposizione contenuta nell’art. 2231 del c.c., che regola la mancata iscrizione in albi o elenchi, si applica solo a chi svolge le professioni intellettuali. La nullità prevista dall’art. 2231 c.c. ricorre, pertanto, soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge alla iscrizione ad apposito albo o ad una abilitazione (Cass. n. 13342 /2018 e Cass. n. 14085/2010). Al di fuori di tale attività vige invece il principio generale di libertà del lavoro autonomo o libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Nel caso dell’autoriparatore, trattandosi di un’opera artigiana, non vi è norma di legge che subordina il diritto al compenso all’iscrizione in albi, e conseguentemente il lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l’opera svolta, anche se privo di partita I.V.A., in quanto le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici. I giudici della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 8453 del 24.3.2023, ha rigettato perciò il ricorso proposto dal cliente, condannandolo al pagamento delle spese legali a favore del meccanico.
Scheda di sintesi sulle principali novità della mediazione civile e commerciale