Al pre-commissario del concordato preventivo è dovuto il compenso pieno

Tempo di lettura: 2 minuti LA CORTE DI CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO DEGLI AVVOCATI DELLO STUDIO TMC Importante pronuncia della Suprema Corte (n. 15790 del 6 giugno 2023), che pone ordine nelle incertezza applicative e nelle prassi difformi adottate nei vari tribunali, circa i criteri di liquidazione del compenso dovuto al “pre-commissario” del vecchio concordato preventivo “con riserva”. I giudici di legittimità, in accoglimento del ricorso dei pre-commissari di un concordato “con riserva”, ha confermato che la determinazione del compenso va sempre operata secondo le disposizioni dell’art. 5 del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30. In assenza di precedenti pronunce negli esatti termini della questione sottoposta, la Corte ha ribadito che il “pre-commissario” – nominato ai sensi del l’art. 161 comma n. 6 della legge fallimentare ante riforma – non è un ausiliario della giustizia, ma un organo della procedura di concordato preventivo. La decisione riordina e alcuni principi pratici destinati a porsi come riferimento in materia: 1. ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nelle due fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l’art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi invece fare sempre riferimento all’attivo inventariato; 2. in caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche nella fase pre-concordataria, in assenza di redazione dell’inventario, i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, e in particolare, ai fini del passivo, dall’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti (eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171 legge fall.) e, ai fini dell’attivo, dall’ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dal commissario) – nonché, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dichiarazione IRAP concernenti l’ultimo esercizio – oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell’impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, legge fall.), o infine dal piano concordatario, se già depositato dal debitore; 3. in tutti i casi di cessazione anticipata dell’incarico, prima che la procedura concordataria giunga a compimento, la determinazione del compenso al commissario giudiziale si effettua «tenuto conto dell’opera prestata», ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. n. 30 del 2012 (richiamato dall’art. 5, comma 5, D.M. cit.), secondo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell’opera prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime previste dall’art. 1, D.M. cit. (richiamate dallo stesso art. 5) e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall’art. 4, comma 1, D.M. cit.
Novità Mediazione Civile e Commerciale

Tempo di lettura: 2 minuti A partire dal 30 giugno sono entrate in vigore le nuove regole che ampliano le materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, tali regole, inoltre, incidono sulle modalità procedimentali, all’istituzione del patrocinio a spese dello Stato ed all’ampliamento degli incentivi fiscali. Di seguito le principali novità sulla procedura: Ti invitiamo a prendere visione dello schema di sintesi in formato pdf al link di seguito.
Scheda di sintesi sulle principali novità della mediazione civile e commerciale
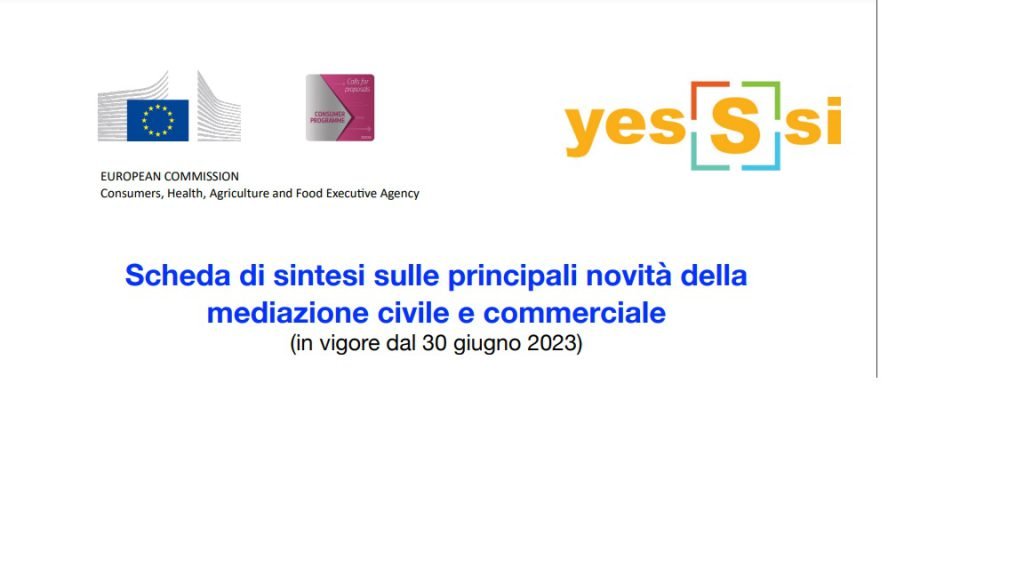
Caduta in Piscina: Chi Paga i Danni?

Tempo di lettura: 3 minuti Brutta caduta per una signora mentre camminava a piedi nudi sul bordo della piscina ed ora chi paga i danni? La signora Tizia era andata alle terme e stava camminando lungo il bordo della piscina all’interno dello stabilimento, quando era caduta violentemente a terra subendo danni fisici e patrimoniali, per i quali aveva chiesto il risarcimento alla società che gestiva la struttura. Di fronte al rifiuto dell’azienda termale, la infortunata aveva agito innanzi al tribunale civile, che però aveva rigettato la domanda, affermando che la vittima della caduta aveva tenuto una condotta imprudente, percorrendo a piedi nudi il bordo della piscina, prevedibilmente e normalmente scivoloso, tanto più perché posto in all’aperto. La corte di appello aveva confermato poi la decisione, condividendo le stesse motivazioni esposte dal giudice di primo grado, e la infortunata aveva deciso così di rivolgere le sue doglianze ai giudici di legittimità. La vicenda ha consentito alla Corte di cassazione di chiarire, con l’ordinanza n. 21675 del 20 luglio 2023, l’importanza della valutazione del comportamento del danneggiato al fine di accogliere, ovvero di escludere, il diritto al risarcimento nei casi di danni da cose in custodia. Per i giudici di legittimità, quando il danneggiato tiene un atteggiamento incauto, è necessario stabilire se il danno sia stato comunque causato dalla cosa, o piuttosto dal comportamento della stessa vittima, o infine se abbiano contribuito entrambi i fattori, e tale indagine deve procedere alla individuazione della causa determinante dell’evento bilanciando i doveri di precauzione (di chi custodisca la cosa) e di cautela (a cui è tenuto l’infortunato). Quando la condotta del danneggiato si presenta come un contributo intenso e rilevante per la produzione dell’evento, rispetto al quale la cosa abbia costituito una mera occasione dell’infortunio, viene meno il rapporto causale con essa. In altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela a cui sono tenute tutte le persone, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione Italiana. Quanto più la situazione di pericolo (e di possibile danno) è prevedibile e può essere superata con l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più deve ritenersi rilevante l’apporto fornito all’infortunio dal comportamento imprudente dello stesso. Nei casi di imprudenza più grave, l’apporto della condotta dell’infortunato può costituire la causa principale di quanto accaduto, escludendo il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Nel caso della signora Tizia, la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative costituiva indice di una possibile colpa imputabile al gestore o al custode della piscina, ma era apparsa meno intensa – sul piano del contributo causale – rispetto alla condotta incauta della vittima, talmente grave da apparire preponderante e decisiva nella ricostruzione della causa del fatto. Sia il tribunale che la corte di appello avevano svolto correttamente un bilanciamento tra la pericolosità della cosa (il bordo piscina umido) e gli obblighi di cautela dell’utente, concludendo entrambe per la sussistenza della pericolosità, ma, allo stesso tempo, per l’agevole prevedibilità e percepibilità della stessa, trattandosi di piscina all’aperto, e per la colpevole scelta di non premunirsi degli accorgimenti minimi per evitare di subirne gli effetti, camminando la vittima a piedi nudi. Il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano accorgimenti proprio assumendo l’ipotesi di simili passi, non significa che, potendosi verificare e percepire la scivolosità del terreno, l’utente sia in diritto in diritto di ignorare le ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare autonomamente, la catena causale autonoma che esclude il suo diritto al risarcimento. Il ricorso della signora Tizia è stato perciò rigettato dalla Corte di Cassazione.
Furto d’auto in Parcheggio Meccanizzato

Tempo di lettura: 3 minuti Prima di prendere l’aereo per il viaggio programmato, Tizia aveva lasciato l’auto in una delle aree di parcheggio a pagamento poste vicino all’aeroporto, chiusa da una sbarra meccanizzata di accesso, dopo aver ritirato il biglietto di ingresso dalla centralina a lato del varco. Al suo ritorno, però, aveva avuto l’amara sorpresa di non trovare più l’auto, e per giunta la società che gestiva l’area non aveva voluto risarcirle il furto, sostenendo che le condizioni generali del contratto di parcheggio escludevano espressamente l’obbligo di custodia dei veicoli parcheggiati. Tizia aveva deciso perciò di investire della questione il Tribunale di Mantova, che però aveva qualificato il contratto stipulato tra le parti come un contratto di parcheggio privo di custodia, e conseguentemente aveva rigettato la domanda. Allo stesso modo si era regolata la Corte d’appello di Brescia, che aveva rigettato l’impugnazione per la medesima ragione, aggiungendo che la fattispecie doveva essere inquadrata nell’ipotesi del contratto di locazione atipico di un’area, che non determina un obbligo di custodia del bene che viene collocato su di essa a fronte del pagamento della tariffa. Per i giudici di secondo grado, nell’ipotesi del parcheggio meccanizzato, l’obbligazione della società che gestisce l’area è quella di garantire al cliente la disponibilità dello spazio in cui viene parcheggiato il veicolo, poiché le modalità di deposito del bene non risultano idonee ad ingenerare nei clienti alcun affidamento circa l’inclusione della custodia del servizio di parcheggio con custodia. Tizia decideva pertanto di ricorrere alla Corte di Cassazione, protestando per la erronea riconduzione del contratto atipico di parcheggio meccanizzato nell’ambito del contratto di locazione atipico, con esclusione dell’obbligo di custodia, piuttosto che nell’ambito del contratto di deposito. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso di Tizia, ha ribaltato però le decisioni dei gradi di merito con l’ordinanza n. 18277 del 27 giugno 2023, riconoscendo il diritto al risarcimento della ricorrente. Secondo i giudici di legittimità, il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento è senz’altro un contratto tipico dal punto di vista sociale, che si caratterizza per la formazione dell’incontro tra l’offerta della prestazione di parcheggio e l’accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l’immissione del veicolo nell’area di parcheggio. È innegabile, infatti, che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo, e pertanto deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia normalmente ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo. Una eventuale deroga al principio generale della custodia del parcheggio necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, che non può essere sostituita dalla semplice apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all’entrata o contenute nel regolamento affisso all’interno dell’area di parcheggio. Per la Cassazione, un’eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l’utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l’offerta, e doveva essere approvata specificatamente per iscritto stante il suo carattere vessatorio. Viceversa, le segnalazioni che vengono operate in un momento successivo alla conclusione del contratto stesso, che si colloca nel momento in cui l’utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso, sono inidonee ad incidere sul contenuto di un contratto già concluso. La sentenza impugnata è stata perciò cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.
La Conversione Religiosa Giustifica l’Addebito della Separazione?

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo alcuni anni di matrimonio, Tizia e Caio avevano deciso di separarsi, e ciascuno aveva imputato all’altro la colpa del fallimento dell’unione. Caio aveva chiesto che la colpa della separazione fosse addebitata alla moglie, poiché lei aveva abbracciato una fede religiosa diversa, le cui pratiche l’avevano distratta da ogni attenzione e cura verso il marito e la famiglia. La concomitanza tra la conversione religiosa ed il mutamento del comportamento di Tizia era stata confermata in aula da un testimone. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato, però, la richiesta di addebito della separazione a danno della moglie, e la decisione era stata confermata dalla Corte di Appello, a cui aveva fatto ricorso il marito. Per i giudici di merito, il mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, corrispondeva all’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 Cost., non potendo di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione, sempre che l’adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge previsti dall’art. 143 c.c., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza. Avevano poi affermato che la violazione dei doveri coniugali ascritta a Tizia, in termini di atteggiamenti di indifferenza verso il marito (tanto da non occuparsi più delle faccende domestiche), non aveva trovato adeguata conferma nella deposizione testimoniale raccolta, Secondo i giudici del merito, anche la scelta di Tizia di dedicarsi alla congregazione religiosa o di trascorrere tempo davanti al computer non aveva avuto un’effettiva incidenza causale, perché si era inserita nel complessivo progetto di vita di “separati in casa” della coppia. Caio ha proposto però ricorso alla Corte di Cassazione, chiedendo che venisse riconosciuta la contrarietà alla legge della decisione di appello, ed ottenendo il ribaltamento della decisione assunta – sul punto – nei due gradi di merito con l’ordinanza n. 19502 del 10.7.2023. Per i giudici della Cassazione, non può esservi dubbio sul fatto che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale debba ricollegarsi in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi. Deve essere perciò dimostrato il rapporto di causa ad effetto tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza; ragion per cui, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, non è possibile pronunciare la separazione con addebito. Il giudice di merito, tuttavia, se ritiene che una determinata condotta, che di per sé risulterebbe in violazione dei doveri conseguenti al matrimonio, non è idonea a giustificare l’addebito della separazione ai sensi dell’art. 151 c.c., essendo non la causa del fallimento dell’unione matrimoniale ma la conseguenza di una situazione di crisi già irrimediabilmente in atto, è tenuto a basare un tale convincimento sulla descrizione dettagliata della situazione di vita creatasi fra i coniugi prima di quella condotta e della prova della crisi già esplora in precedenza. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli aveva fatto riferimento ad una situazione di “reciproca sostanziale autonomia di vita”, testimoniata dal fatto che i due coniugi dormivano separati, ma non aveva spiegato se quella scelta era stata antecedente o successiva alla conversione religiosa della moglie. La Corte di Cassazione ha rilevato, inoltre, che il teste ascoltato dal tribunale aveva riferito degli atteggiamenti di disaffezione costituiti dal fatto che Tizia si era rifiutata di cucinare, di occuparsi della casa e del bucato, ma ha raccontato pure di continue denigrazioni. Questo atteggiamento, che era stato ignorato dalla Corte di merito, ove fosse consistito in un comportamento moralmente violento, doveva essere considerato incompatibile con gli obblighi di assistenza morale e materiale e collaborazione nell’interesse della famiglia a cui ciascuno dei coniugi è tenuto ex art. 143, comma 2, c.c., tanto da assumere una incidenza causale effettiva e preminente rispetto a qualsiasi causa eventualmente preesistente di crisi del rapporto coniugale. La Suprema Corte ha cassato perciò la sentenza impugnata, rimettendo gli atti alla Corte di Appello di Napoli per una nuova decisione rispettosa dei principi enunciati.
ATTENTI AL CANE: BASTA UN CARTELLO PER NON RISARCIRE?

Tempo di lettura: 3 minuti Tizio stava passeggiando tranquilamente con il proprio cane, ma all’improvviso vedeva scendere da un’auto un cane di razza pitbull, sfuggito al suo padrone Caio, che si dirigeva di gran carriera verso di lui. Dopo un attimo il pitbull aveva aggredito il cane di Tizio, il quale invano aveva tentato di staccarlo, finendo così per rimediare anche lui un morso alla mano che gli aveva procurato lesioni con una prognosi di guarigione di dieci giorni. Il Giudice di Pace aveva ritenuto il padrone del pitbull colpevole del reato di cui all’art. 590 c.p. e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di Euro 180,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita liquidati in totali Euro 2000,00. Il Giudice monocratico del Tribunale di Reggio Emilia aveva poi confermato la sentenza nel successivo giudizio di impugnazione. Caio ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il suo cane fosse senza guinzaglio, e che era stata ingiustamente ritenuta credibile, per giungere alla sua condanna, la testimonianza resa da Tizio, che si era costituito parte civile. I giudici di legittimità, con la sentenza n. 21821 del 24.7.2023, hanno dichiarato però inammissibile il ricorso di Caio, precisando, con l’occasione, alcuni principi di assoluto interesse per le frequenti vicende simili a quella in esame. La Corte di Cassazione ha ricordato innanzitutto che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione A fronte poi di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Per i giudici della Cassazione, il principio è corretto, ed è collegato alla posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, per la quale egli è tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, pure oggi che è stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosità dell’animale per l’abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto, Pertanto, la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, può essere affermata ove si accerti la violazione degli obblighi di custodia, ed al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee. La Corte ha ricordato, inoltre, come di recente avesse già ritenuto che un cartello “ATTENTI AL CANE” ben in vista al cancello d’ingresso della villetta non bastasse, da solo, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone. Nel caso in esame, peraltro, la circostanza che il cane fosse al guinzaglio risultava smentita dalle stesse dichiarazioni rese da Caio, il quale aveva affermato che il cane aveva il guinzaglio ma “se lo è trascinato dietro”.
Bollo auto: prescrizione decorsi tre anni

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 625 del 2021 ha ribadito il più recente principio giurisprudenziale che fissa in tre anni il termine di prescrizione della tassa di circolazione degli autoveicolo. Già la Corte di Cassazione, con la sentenza a sezione unite n. 23397 del 2016, aveva fissato il diverso principio, ora confermato anche dal giudice tributario di appello. La decisione si inserisce quindi nel solco di un filone giurisprudenziale divenuto ormai costante, e fuga definitivamente le contrastanti, ma più datate, interpretazioni che fissavano il termine di prescrizione nel più lungo termine decennale.
